 A differenza di Lev Tolstoj e di altri scrittori e drammaturghi del periodo in cui vive, Anton Čechov ritiene di non aver alcun messaggio da comunicare agli uomini ed il suo rapporto con la letteratura è piuttosto ombroso. Privo di illusioni, descrive mirabilmente il lento e monotono fluire della vita, senza curarsi minimamente di attribuire un senso alla nostra esistenza. D’altronde la vita, sembra suggerirci attraverso le sue opere, non ha alcun senso, è quello che è, e l’unica cosa che possiamo fare è quella di ascoltarla dentro di noi e nel mondo che ci circonda.
A differenza di Lev Tolstoj e di altri scrittori e drammaturghi del periodo in cui vive, Anton Čechov ritiene di non aver alcun messaggio da comunicare agli uomini ed il suo rapporto con la letteratura è piuttosto ombroso. Privo di illusioni, descrive mirabilmente il lento e monotono fluire della vita, senza curarsi minimamente di attribuire un senso alla nostra esistenza. D’altronde la vita, sembra suggerirci attraverso le sue opere, non ha alcun senso, è quello che è, e l’unica cosa che possiamo fare è quella di ascoltarla dentro di noi e nel mondo che ci circonda.
Čechov asserisce che per creare un buon racconto sarebbe necessario immaginare un evento da cui sia poi possibile poter eliminare l’inizio e la fine. Ciò scaturisce dalla sua consapevolezza che la vita sia semplicemente l’oggetto di una rappresentazione artistica, senza principio e senza finale. Tale premessa ci consente di capire il motivo per cui lo scrittore russo affermi di non essere in grado di scrivere un romanzo, mentre in realtà lo fa, inconsapevolmente, attraverso i suoi racconti che, ad un’analisi approfondita, sono dei capitoli di uno stesso romanzo. Racconti dunque senza alcun principio e senza alcuna fine dell’immensa storia che vuole narrare al mondo, la storia quotidiana del suo popolo negli ultimi anni dell’Ottocento.
Lo stesso principio applicherà alle sue commedie che mostrano un nuovo modo di concepire il teatro privandolo di tutti gli schemi e i trucchi ottocenteschi per poter raggiungere lo scopo di rappresentare la vita direttamente sul palcoscenico.
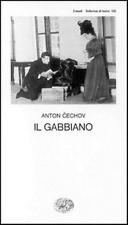 Può esserci d’aiuto la conversazione che Čechov sostiene con il poeta Sergey Gorodeckiy e che sarà riportata in parte nella commedia “Il gabbiano” attraverso le parole del drammaturgo rivoluzionario Treplëv per meglio comprendere il suo pensiero: «Si esigono eroi, eroismo, ed eroismo che produca effetti scenici. Pure nella vita non si spara, non ci si impicca, non si dichiara il proprio amore e non si enunciano pensieri profondi tutti i giorni e a getto continuo. No, quasi sempre nella vita si mangia, si beve, si fa all’amore, si dicono delle sciocchezze. È tutto questo che si deve vedere sul palcoscenico. Bisogna scrivere una commedia in cui le persone vanno, vengono, pranzano, parlano della pioggia e del sole, giocano alle carte non per volontà dell’autore, ma perché tutto questo avviene nella vita reale».
Può esserci d’aiuto la conversazione che Čechov sostiene con il poeta Sergey Gorodeckiy e che sarà riportata in parte nella commedia “Il gabbiano” attraverso le parole del drammaturgo rivoluzionario Treplëv per meglio comprendere il suo pensiero: «Si esigono eroi, eroismo, ed eroismo che produca effetti scenici. Pure nella vita non si spara, non ci si impicca, non si dichiara il proprio amore e non si enunciano pensieri profondi tutti i giorni e a getto continuo. No, quasi sempre nella vita si mangia, si beve, si fa all’amore, si dicono delle sciocchezze. È tutto questo che si deve vedere sul palcoscenico. Bisogna scrivere una commedia in cui le persone vanno, vengono, pranzano, parlano della pioggia e del sole, giocano alle carte non per volontà dell’autore, ma perché tutto questo avviene nella vita reale».
Questo pensiero ci riporta immediatamente al Naturalismo di Zola, ma l’autore si affretta a precisare che il suo non è: « […]né naturalismo né realismo. Bisogna lasciare la vita qual è, gli uomini quali sono, veri e non gonfi di retorica».
 Nato a Taganrog il 29 gennaio del 1860 da una famiglia di umili origini, così descrive il grande scrittore, drammaturgo e medico russo quel cosiddetto “periodo magico” della vita che purtroppo, più spesso di quanto si pensi, viene negato ai bambini: «Mio padre cominciò a educarmi, o più semplicemente a picchiarmi, quando non avevo ancora cinque anni. Ogni mattina, al risveglio, il primo pensiero era: oggi sarò picchiato? Sono stato allevato nella religione, ho cantato nel coro, o letto gli Apostoli e i salmi in chiesa, ho assistito regolarmente ai mattutini, ho persino aiutato a servir messa e ho suonato le campane. E qual è il risultato di tutto ciò? Non ho avuto infanzia. E non ho più alcun sentimento religioso. L’infanzia per i miei fratelli e per me è stata un’autentica sofferenza».
Nato a Taganrog il 29 gennaio del 1860 da una famiglia di umili origini, così descrive il grande scrittore, drammaturgo e medico russo quel cosiddetto “periodo magico” della vita che purtroppo, più spesso di quanto si pensi, viene negato ai bambini: «Mio padre cominciò a educarmi, o più semplicemente a picchiarmi, quando non avevo ancora cinque anni. Ogni mattina, al risveglio, il primo pensiero era: oggi sarò picchiato? Sono stato allevato nella religione, ho cantato nel coro, o letto gli Apostoli e i salmi in chiesa, ho assistito regolarmente ai mattutini, ho persino aiutato a servir messa e ho suonato le campane. E qual è il risultato di tutto ciò? Non ho avuto infanzia. E non ho più alcun sentimento religioso. L’infanzia per i miei fratelli e per me è stata un’autentica sofferenza».
Il padre, un uomo dispotico ed estremamente religioso, ha una modesta drogheria e costringe la famiglia a sottostare ai dettami della sua fede cattolica, a permanere per ore in luoghi gelidi e a seguirlo quotidianamente ad assistere alle funzioni principali che si svolgono in chiesa. La madre, sottomessa al marito, viene quotidianamente maltrattata e conduce la sua esistenza silenziosamente, senza mai ribellarsi. La sua immensa dolcezza scalda l’animo del futuro scrittore che così esprime il suo profondo amore: «Per me non esiste nulla di più caro di mia madre in questo mondo pieno di cattiveria».
Non particolarmente brillante negli studi inizialmente, a causa dei numerosi impegni per aiutare il padre e la mancanza di stimoli dovuta ad insegnanti che lo stesso scrittore definirà “miserabili funzionari“, conclude il liceo in modo eccellente e ottiene una borsa di studio che gli consente di accedere all’università.
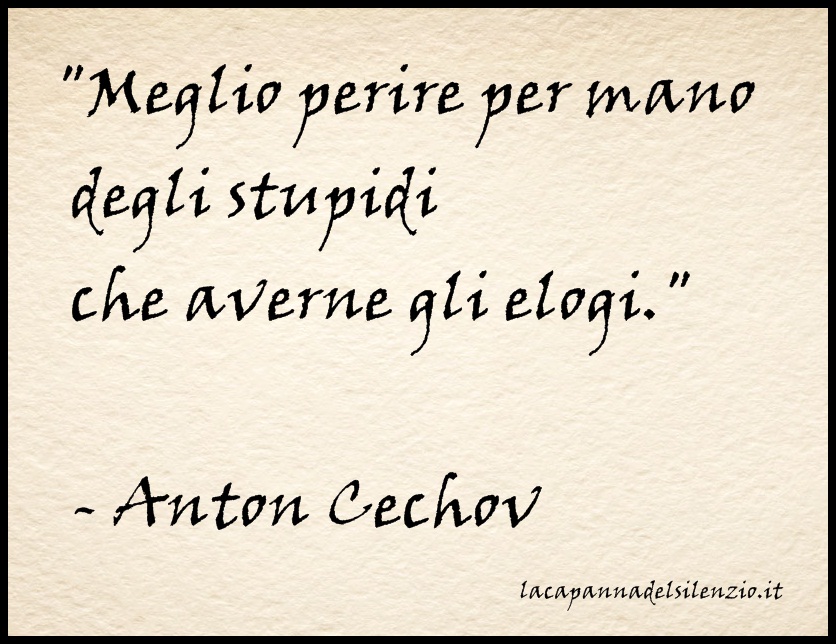
Attento osservatore della vita quotidiana, mentre frequenta l’università, comincia a collaborare con giornali e riviste scrivendo brevi racconti umoristici e firmandoli con diversi pseudonimi a causa della vergogna di tale attività costretto a condurre per ricavarne un modesto guadagno.
Un noto critico, a proposito di questo esordio letterario di Čechov, scriverà che l’autore comincia ad affacciarsi al mondo della letteratura scrivendo barzellette e concluderà tale percorso con l’angoscia.
Commento poco pertinente visto che l’atteggiamento dello scrittore nei confronti della vita resterà immutato persino quando sarà colpito da una malattia incurabile. L’ironia e il sorriso non smetteranno di tenergli compagnia nemmeno nel momento più buio della sua vita. Vicino alla morte, infatti, continuerà a sorridere e a fare in modo da non recare alcun disturbo alle persone care.

Laureatosi in medicina nel 1884, esercita la sua professione saltuariamente e consacrandola soprattutto al popolo affamato e colpito da epidemie. Il rapporto conflittuale e logorante del suo lavoro di medico lo condurrà poi ad abbandonare tale professione, per dedicarsi a quella che denomina “l’amante del cuore“, la letteratura.
La medicina viene da lui definita invece la “moglie legittima“, un campo che decide di lasciare quando si rende conto che tutte le conoscenze acquisite non gli impediscono di salvare la vita ad una ragazza o ad un bambino.
Scrive più di duecento racconti e numerosi drammi, ancora oggi rappresentati dappertutto con grandissimo successo. Si ammala di tubercolosi e soggiorna varie volte in sanatori per cercare di debellare il male che lo affligge. Si sposa nel 1901 con l’attrice di teatro Olga Knipper e si spegne, dopo l’ultimo tentativo di sconfiggere la malattia, il quindici luglio del 1904, a soli quarantaquattro anni.
Prima di chiudere per sempre gli occhi domanda un bicchiere di champagne e lo svuota lentamente.
La visione cupa della vita è ben evidente nelle opere di Anton Čechov. Con uno stile semplice e privo di fronzoli, che rigetta il bagaglio altisonante del teatro ottocentesco, lo scrittore russo mette a nudo la tragedia quotidiana dell’uomo e scuote la palude letteraria del periodo reazionario in cui vive mettendo sotto accusa la società del suo tempo.
Le quotidiane pene che l’uomo deve affrontare in un’esistenza di cui nessuno conosce il significato vengono messe in atto nei suoi racconti attraverso personaggi spesso fraintesi e vessati, che cercano di dare un senso alla loro misera esistenza senza averne alcun riscontro positivo.
La sua narrativa, inizialmente influenzata dallo stile comico e grottesco di Gogol, acquisisce presto una peculiarità che lo contraddistingue dagli altri intellettuali dell’epoca e che si manifesta nel suo cogliere profondamente tutte le sfumature dell’animo umano. Lo scrittore concentra soprattutto la sua attenzione sulla borghesia russa, consapevolmente passiva della sua imminente fine, e sul paesaggio russo.
Tra i suoi più noti racconti non bisogna dimenticare “La steppa“, “Il reparto n.6“, “Il monaco nero“, “Il duello“, “La mia vita“, e “Nel burrone“.
Ne “La steppa” (1888) Čechov ci conduce in un viaggio molto coinvolgente attraverso l’immensa steppa russa, trasformando il paesaggio in un’entità viva e vibrante, quasi magica. Il protagonista, il giovane Egoruška, un bambino di appena nove anni, inizia un cammino che lo allontana da casa per avventurarsi in una nuova fase della sua vita, ma è ciò che lo circonda a diventare il vero cuore pulsante della storia. Le descrizioni della steppa sono così vivide che sembra di udire il soffio del vento, di osservare l’erba ondeggiare sotto il sole cocente o la luna che illumina le lunghe notti. Ogni incontro lungo il percorso rappresenta un frammento d’umanità che arricchisce il racconto, creando un mosaico di voci e destini. Egoruška osserva il mondo con occhi curiosi e affascinati, e attraverso lui, lo scrittore ci invita a cogliere la vastità e la solitudine dell’esistenza, il fascino dell’ignoto e il peso delle prime vere riflessioni sul futuro.
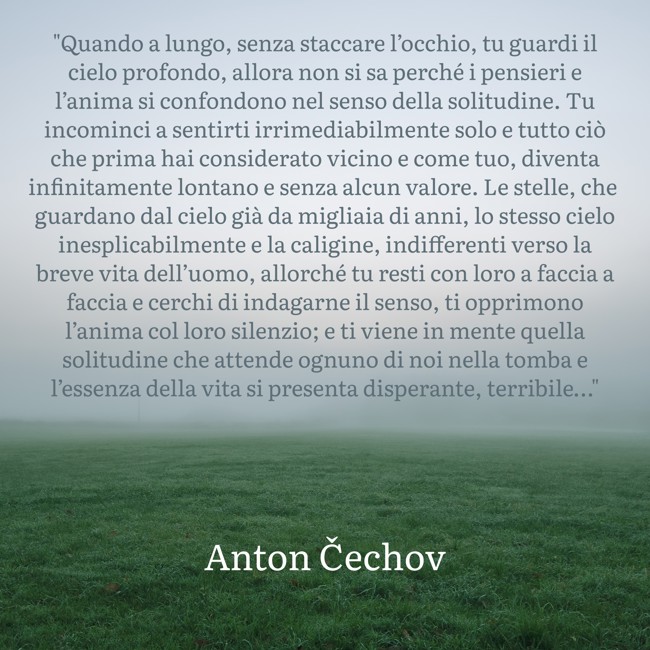
“Il reparto n.6” (1892) crea nei lettori un’intensa sensazione di angoscia. Čechov ci conduce all’interno di un ospedale psichiatrico degradato e desolato, dove follia e sanità mentale si intrecciano in un inquietante confronto. Qui incontriamo il dottor Andreev, un uomo ormai rassegnato e apatico, e Ivan Gromov, un paziente tormentato dalla sua lucidità acuta e dalla sua impellente ricerca di giustizia. Le dinamiche tra i due costituiscono il cuore stesso della storia: Gromov, con la sua passione e fervore, scuote le coscienze del medico, costringendolo ad osservare il mondo da una nuova prospettiva. Tuttavia, questa nuova consapevolezza si rivela una condanna. In un contesto segnato dall’indifferenza e da una crudeltà sistematica, rischiare di oltrepassare la linea diventa facile, venendo etichettati come folli e rinchiusi senza alcuna via di fuga. L’autore esprime una critica feroce alla società, rivelando la sua incapacità di distinguere tra intelligenza e follia, tra rassegnazione e vera malattia ed alla fine del racconto sorge spontanea una domanda: Chi sono i veri pazzi? Coloro che vengono rinchiusi o una società malata che decide di confinare chi non si adegua ad essa?
“Il monaco nero” (1894) è un altro racconto che tratta il tema della follia, catturando l’attenzione fin dalle prime pagine e mantenendo un’atmosfera di tensione fino alla fine. Un’intelligenza brillante, Kovrin, si trova a fronteggiare un mondo stravolto dalla presenza di un monaco nero, un’apparizione inquietante che mette in discussione i confini tra realtà e immaginazione. Čechov ci conduce in un profondo viaggio psicologico, esplorando l’ossessione e l’ambizione, utilizzando il monaco nero come simbolo delle forze che possono condurre una persona alla rovina. La narrazione, ricca di introspezione e colpi di scena, ci invita a riflettere su fino a che punto possiamo arrivare senza perdere il contatto con la realtà. Questo racconto non si limita solamente a coinvolgerci, ma è anche una profonda esplorazione della psicologia umana. Il nostro scrittore riesce a mescolare in modo magistrale bellezza e paura, dando vita a un’opera che ci travolge con emozioni contrastanti e pensieri che continuano a risuonare.
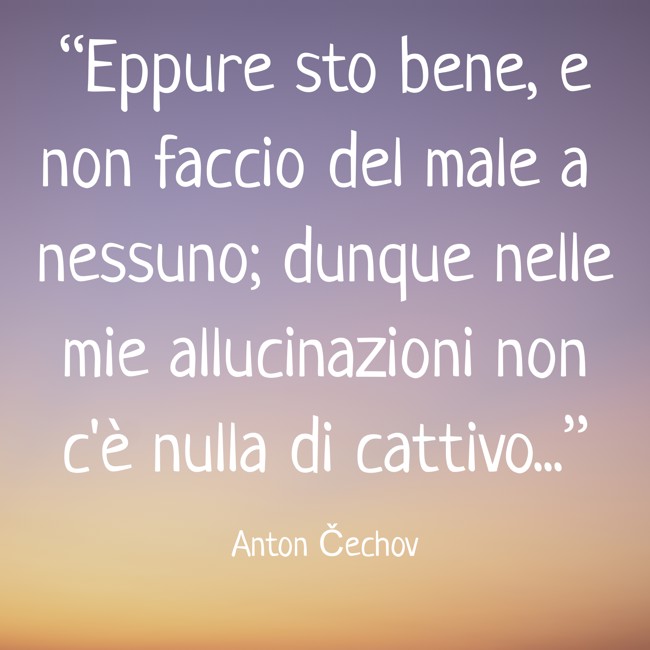
“Il duello” (1891) è anch’esso un racconto ricco di tensione e introspezione, in cui Čechov mette a confronto due visioni diametralmente opposte della vita e dell’umanità. Da una parte c’è Laevskij, un uomo in crisi, incapace di dare una direzione alla sua esistenza, insoddisfatto del suo amore e prigioniero delle proprie insicurezze. Dall’altra parte troviamo Von Koren, una persona fredda e analitica, convinta che solo i forti abbiano diritto di vivere e che individui indecisi come Laevskij siano un peso per la società. L’atmosfera è carica di tensione: l’ostilità tra i due si intensifica con il progredire della narrazione, fino a culminare in un vero e proprio duello. Tuttavia, ciò che rende questa storia particolarmente affascinante non è solo il confronto fisico, ma il conflitto tra due ideologie inconciliabili. L’autore, grazie alla sua straordinaria abilità nel sondare l’animo umano, non prende posizione: entrambi i protagonisti hanno le loro ragioni e le loro colpe, lasciando il lettore a riflettere sulla complessità della natura umana. Il paesaggio del Caucaso, descritto con dettagli evocativi, rispecchia le emozioni e i conflitti interiori dei personaggi, amplificando il senso di inquietudine e incertezza che permea l’intera narrazione. Il duello non è solo una storia di rivalità e ideologie in conflitto, ma un racconto che ci obbliga a confrontarci con le nostre debolezze, paure e la possibilità – o impossibilità – di un cambiamento. Un’opera intensa e straordinariamente attuale, che lascia il lettore con molti interrogativi sospesi.
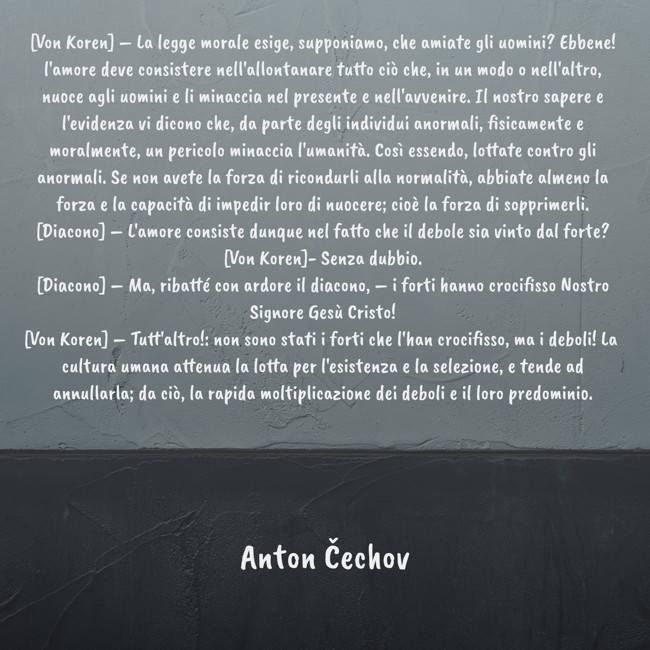
Sogni infranti, ribellione e disillusione caratterizzano il racconto “La mia vita” (1896). Il protagonista, Misail, è un giovane che rifiuta la strada tracciata dalla sua famiglia e sceglie di svolgere il lavoro di operaio. È convinto che nel lavoro manuale vi sia dignità, autenticità e un significato profondo dell’esistenza. Tuttavia, la realtà si presenta ben diversa. Il suo gesto di ribellione non lo conduce alla libertà tanto da lui agognata ma ad una lenta e inesorabile emarginazione: la borghesia lo disprezza per aver rinunciato al suo status, mentre la classe operaia lo osserva con sospetto. Anche il suo matrimonio con Marija, una donna che inizialmente condivideva i suoi ideali, si trasforma in una prigione emotiva, segnata da incomprensioni e illusioni infrante.
Čechov non offre risposte e, con il suo stile asciutto e incisivo racconta, ancora una volta, senza esprimere giudizi, facendo emergere la complessità della condizione umana. Il racconto ritrae un uomo che lotta per rimanere fedele ai propri principi in un mondo che sembra respingerlo da ogni direzione. Una storia universale, dunque. Una storia che si rivolge a chiunque abbia mai tentato di vivere secondo i propri ideali, affrontando la durezza della realtà. Alla fine, sorge una domanda: è possibile costruire un’esistenza autentica scevra da compromessi? O la vita è destinata a spegnere ogni sogno? Lo scrittore non fornisce alcuna risposta, ma lascia in noi lettori una profonda inquietudine e una riflessione che perdura ben oltre l’ultima pagina.
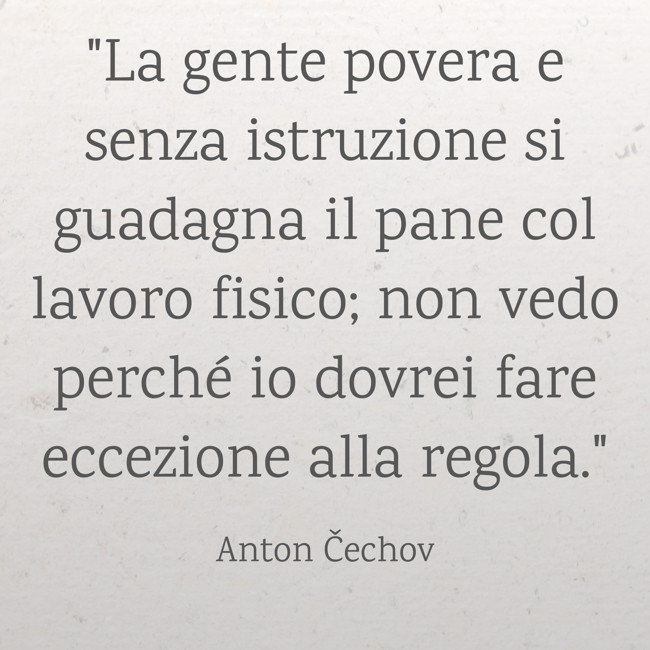
Nel burrone (1900) il nostro scrittore ci trascina nelle ombre di una società tormentata da avidità e disperazione. La narrazione si snoda in un remoto villaggio russo, dove la famiglia Tsybukin, una famiglia di mercanti senza scrupoli, edifica la propria fortuna a spese di contadini poveri e ignoranti, intrappolati in una miseria apparentemente senza via d’uscita. Tuttavia, la ricchezza non genera né pace né felicità. Ogni personaggio vive un’inquietudine profonda: chi possiede il denaro teme di perderlo, mentre chi è privo di beni affronta l’eterna frustrazione di non poter mutare il proprio destino. Con crudo realismo viene rappresentato un mondo in cui l’empatia viene soffocata dalla lotta quotidiana per la sopravvivenza. E il burrone non è solo un elemento paesaggistico, ma rappresenta un potente simbolo della frattura insanabile tra ricchi e poveri, tra chi comanda e chi subisce. Non è solo una semplice storia, ma un affresco cupo e straordinariamente attuale sulle disuguaglianze sociali e sulla corruzione dell’animo umano.
Una menzione particolare ai quattro quaderni di appunti biografici, “I quaderni del dottor Čechov“, in cui si può comprendere ulteriormente il suo pensiero.

Notevole la sua produzione teatrale che comprende capolavori ancora oggi di estremo interesse quali il già menzionato “Il gabbiano” “Ivanov“, “Zio Vanja” e “Il giardino dei ciliegi“.
Il teatro del grande autore russo è innovativo nella sua assenza di un protagonista e nei lunghi silenzi che attraversano le rappresentazioni sceniche contornate da personaggi abulici e alienati con palesi difficoltà di comunicazione. Quell’atmosfera sonnambula di perenne attesa anticipa i temi successivi della drammaturgia occidentale. I suoi personaggi manifestano la prerogativa tipicamente umana di sciupare la propria vita, trascinandosi in un’esistenza priva di sogni, o, al contrario, scontrandosi con l’amara disillusione per aver sognato e preteso molto nel loro percorso su questa terra.
Nel teatro prettamente lirico di Čechov la trama è quasi inesistente e gli eventi più significativi che investono la vita dei protagonisti avvengono fuori dalla scena. L’azione viene sostituita dalla rappresentazione sommessa dei vari stati d’animo dei personaggi e non si prevede alcun finale. Gli episodi più significativi che si devono sapere sono già accaduti o vengono raccontati quando comincia la commedia. Gli spettatori assistono quindi ad un momento della vita di alcuni personaggi.
Le tematiche ricorrenti del teatro e della narrativa di Čechov si possono racchiudere in quel lento fluire di una vita che assiste indifferente al consumarsi della tragedia degli uomini, la vanità delle passioni umane e l’impossibilità dei personaggi di liberarsi dalla gabbia del proprio tragico destino.
Considerato uno dei più grandi scrittori della letteratura russa, per l’originalità del suo stile e per la capacità di guardare la vita in modo semplice e complesso nello stesso tempo, Čechov riesce a rilevare gli aspetti più tristi e nascosti della natura umana con un certo distacco che ne attenua la tragicità.
Ne “Il gabbiano“(1895) l’autore ci conduce in una tenuta di campagna, lontana dal trambusto cittadino, ma intrisa di emozioni contrastanti. Qui si muovono personaggi profondamente umani, ognuno intrappolato nel proprio tormento interiore: c’è Konstantin Treplev, un giovane scrittore alla ricerca di una nuova forma d’arte, e Nina, una ragazza che sogna di diventare un’attrice di successo. Tuttavia, i loro ideali si scontrano ben presto con una realtà dura, punteggiata da disillusioni, indifferenza e amori impossibili. Il dramma della vita viene narrato senza mai alzare la voce, senza grandi scene di conflitto, colpi di scena spettacolari o momenti di catarsi. Piuttosto, c’è una lenta e sottile erosione dei sogni, un sentimento di malinconia che si intensifica scena dopo scena, fino a lasciare il lettore (o lo spettatore) con una sensazione di vuoto difficile da colmare. Il simbolo del gabbiano, fragile e libero al contempo, diventa l’emblema di un desiderio di volare che, troppo spesso, si spezza.
“Ivanov” (1887) è il commovente ritratto di un uomo intrappolato in una vita che non gli appartiene più. Nikolaj Ivanov è stato, un tempo, un uomo ricco di idee, ambizioni e speranze. Oggi, invece, è consumato dalla noia, dall’insoddisfazione e da un’ansia che non riesce nemmeno a spiegare a se stesso. Sua moglie Anna è affetta da tubercolosi e lui, invece di offrirle il suo sostegno, si allontana sempre di più, schiacciato da responsabilità e da un senso di colpa che non lo abbandona. Tuttavia, Ivanov non è solo la storia di un matrimonio in crisi o di un uomo sul bordo del baratro. È il ritratto di un’anima in conflitto, di qualcuno che si sente bloccato in un mondo che non lo comprende e che lui stesso non riesce più a tollerare. Čechov non ci presenta un eroe, ma un uomo profondamente umano, con tutte le sue contraddizioni, debolezze e un disperato desiderio di fuggire da una realtà che lo opprime. Il finale, amaro e sconvolgente, suscita in noi un interrogativo difficile da ignorare: cosa succede quando un uomo smette di credere in se stesso e nel futuro? L’opera tocca corde profonde e ci costringe a guardare dentro di noi, domandandoci se, in fondo, non ci sia un po’ di Ivanov in ognuno di noi.
Nell’opera “Zio Vanja” (1897) Čechov ci conduce in una tranquilla tenuta di campagna, dove il tempo scorre lento, ma le emozioni si aggrappano con forza sotto la superficie. Qui vive Vanja, un uomo che ha sacrificato tutta la sua vita per sostenere il cognato Serebrjakov, un professore da lui considerato estremamente dotato, ma che si rivela essere solo un individuo egoista e mediocre. Quando l’anziano accademico torna a casa con la sua giovane e affascinante moglie Elena, l’equilibrio fragile inizia a sfaldarsi, e tutte le frustrazioni accumulate iniziano a emergere. Al centro della narrazione c’è un insopportabile senso di perdita: Vanja si rende conto di aver dedicato la propria vita ad un ideale infondato, mentre Sonja, sua nipote, ama senza speranza un uomo che non le riserverà mai lo stesso sentimento. E poi c’è Astrov, il medico idealista e disilluso, che sogna un mondo migliore ma si sente sopraffatto dal cinismo e dalla rassegnazione. Ogni personaggio persegue qualcosa di inaccessibile, mentre la vita scorre inesorabile, lasciandoli sospesi tra desideri e rimpianti. “Zio Vanja“ è una storia che parla profondamente a ciascuno di noi, perché chi non ha mai affrontato la frustrazione di un sogno svanito, di un amore non corrisposto o di un’occasione persa? Il nostro drammaturgo ci presenta, infatti, un riflesso della nostra esistenza, facendoci sentire meno isolati nella nostra imperfetta e vulnerabile umanità.
“Il giardino dei ciliegi” (1902-1903), l’ultimo lavoro di Čechov, racchiude nostalgia, cambiamento e perdita in un racconto tanto delicato quanto intenso. La trama si concentra sulla famiglia aristocratica dei Ranevskij, ormai in declino, incapace di affrontare la dura realtà della modernità. Il loro affascinante giardino dei ciliegi, simbolo di un passato glorioso e sereno, è destinato ad essere venduto per ripagare i debiti, ma nessuno di loro ha il coraggio di prendere una decisione. Ljubov, la protagonista, si aggrappa ai ricordi e alla bellezza di un mondo in dissoluzione, mentre Lopachin, un ex servo diventato imprenditore, incarna il nuovo ordine sociale, pronto a abbattere gli alberi del giardino per erigere villette. Il conflitto tra passato e futuro è palpabile, ma il nostro autore non si schiera, come sempre; lascia che siano i personaggi, con le loro fragilità e illusioni, a rivelare il dramma di un cambiamento inevitabile. Nonostante la tristezza che attraversa la storia, l’opera non è cupa. I dialoghi sono pieni di ironia e le scene oscillano tra momenti leggeri e improvvisi sbalzi di malinconia. Alla fine, quando il suono della scure che abbatte gli alberi riempie l’aria, ciò che rimane è un senso di dolce amarezza: la vita prosegue, con o senza di noi. Con questa pièce, il nostro immenso autore riesce a ritrarre in modo autentico la fine di un’epoca e l’incapacità umana di adattarsi ai cambiamenti. È un’opera straordinaria che tocca il cuore attraverso la sua intensa poesia.
Di seguito alcuni suoi pensieri e racconti.
Quel che proviamo quando siamo innamorati è forse la nostra condizione normale. L’amore mostra quale dovrebbe essere l’uomo.
***
Sessantamila abitanti si preoccupano soltanto di mangiare, di bere, di riprodursi e non hanno alcun interesse nella vita […] non ci sono né patrioti, né uomini d’affari, né poeti», e la città è sporca, insignificante, pigra, ignorante e noiosa. Non vi è neppure un’insegna che sia priva di errori d’ortografia. Le vie sono deserte […] la pigrizia è generale.
***
Che fortuna possedere una grande intelligenza: non ti mancano mai le sciocchezze da dire.
***
Può essere bello solo ciò che è grave.
***
Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità.
***
Una volta nel gregge, è inutile che abbai: scodinzola!
***
Qualsiasi idiota può superare una crisi; è il quotidiano che ti logora.
***
Io volevo dire onestamente alla gente: – Date uno sguardo a voi stessi e vedete come grame e desolate sono le vostre esistenze! – L’importante per me è che la gente si rende conto di ciò, perché, quando lo faccia, riuscirà poi a crearsi un altro e migliore modo di vita. Io non vivrò abbastanza per vederlo, ma so che esso sarà completamente diverso dal nostro. E finché questo differente modo di vita non sia per diventare una realtà, io continuerò a dire alla gente: Per favore, rendetevi conto che la vostra esistenza è grama e desolata! – Non mi pare che ci sia motivo di piangere per questo.
***
Una donna può esser amica di un uomo solamente in questa progressione: dapprima conoscente, poi amante e infine amica.
***
Quando il diluvio ci minaccia, non bisogna temere di bagnarsi i piedi.
***
Medvedenko — Ma perché andate sempre vestita di nero?
Maša — Perché sono infelice. Porto il lutto per la mia povera vita.
( da “Il gabbiano” )
***
Quelli che vivranno dopo di noi, fra due o trecento anni, e ai quali stiamo preparando la strada, ci saranno grati? Si ricorderanno di noi con una buona parola? Balia, non ricorderanno! ( da “Zio Vanja” )
***
Ti si accostano ghignando, ti guardano in cagnesco, ti squadrano, ti etichettano: «Questo, è uno psicopatico» oppure «Quello è un parolaio». E quando non sanno che etichetta appiccicarti in fronte, dicono: «È un uomo strano, proprio strano!» Amo le foreste: è strano. Non mangio carne: anche questo è strano. Un rapporto diretto, pulito, libero con la natura e con la gente non c’è più… ( da Zio Vanja )
***
Fu festeggiato l’anniversario di un uomo molto modesto. E soltanto alla fine del pranzo ci si accorse che qualcuno non era stato invitato: il festeggiato.
***
[Von Koren] La legge morale esige, supponiamo, che amiate gli uomini? Ebbene! l’amore deve consistere nell’allontanare tutto ciò che, in un modo o nell’altro, nuoce agli uomini e li minaccia nel presente e nell’avvenire. Il nostro sapere e l’evidenza vi dicono che, da parte degli individui anormali, fisicamente e moralmente, un pericolo minaccia l’umanità. Così essendo, lottate contro gli anormali. Se non avete la forza di ricondurli alla normalità, abbiate almeno la forza e la capacità di impedir loro di nuocere; cioè la forza di sopprimerli.
[Diacono] L’amore consiste dunque nel fatto che il debole sia vinto dal forte?
[Von Koren] Senza dubbio.
[Diacono] Ma, ribatté con ardore il diacono, – i forti hanno crocifisso Nostro Signore Gesù Cristo!
[Von Koren]Tutt’altro!: non sono stati i forti che l’han crocifisso, ma i deboli! La cultura umana attenua la lotta per l’esistenza e la selezione, e tende ad annullarla; da ciò, la rapida moltiplicazione dei deboli e il loro predominio.
***
I dottori sono simili agli avvocati; la sola differenza è che gli avvocati ti derubano soltanto, mentre i medici ti derubano e per di più ti uccidono. ( da “Ivanov” )
***
[prostitute] Hanno tutte la coscienza del loro peccato e sperano nella salvezza dell’anima; possono usare, nella più larga misura, dei mezzi che vi conducono. La società, è vero, non dimentica il passato delle persone; ma, dinanzi a Dio, Maria l’Egiziana non è inferiore agli altri santi.
***
Cristo ci ha insegnato un amore ragionevole, sensato e utile.
***

I despoti sono sempre stati preda d’illusioni.
***
[Prostituzione] Il vizio esiste ma non vi è in loro, né coscienza di colpa, né speranza di salvezza. Le vendono, le comprano, le annegano nel vino e nelle turpitudini, ma sono bestie come delle pecore, indifferenti, ed incoscienti. Dio mio, Dio mio!
***
Noi uomini ci uccidiamo fra noi; è certamente immorale, ma la filosofia non può farci niente.
***
Forse solo in paradiso l’umanità vivrà per il presente; finora è sempre vissuta d’avvenire.
***
Là dove noi non siamo, si sta bene. Nel passato noi non siamo più ed esso ci appare bellissimo.
***
Non permettere alla lingua di oltrepassare il pensiero.
***
Fra “Dio c’è” e “Dio non c’è” si estende un campo vastissimo, che con grande fatica un autentico saggio attraversa.
***
Una brava persona si vergogna anche di fronte a un cane.
Quando ami, scopri in te una tale ricchezza, tanta dolcezza, affetto, da non credere nemmeno di saper tanto amare.
***
La buona educazione non sta nel non versare la salsa sulla tovaglia, ma nel non mostrare di accorgersi se un altro lo fa.
***
Se avete paura della solitudine, non sposatevi.
***

È più facile chiedere ai poveri che ai ricchi.
***
L’uomo è ciò in cui crede.
***
L’intelligente ama istruirsi, lo stupido istruire.
***
Occupazioni inutili e conversazioni sempre uguali si portano via la parte migliore del tempo, le forze migliori, e alla fine rimane una vita mutilata, senz’ali, una nullità dalla quale non si può fuggire, evadere, come se si fosse in un manicomio o in una squadra di condannati ai lavori forzati!
***
Gli uomini non apprezzano ciò di cui sono ricchi. “Quel che possediamo, non lo custodiamo”; non basta: quel che possediamo, non l’amiamo.
***
La vita è passata ed io non mi sono neanche accorto.
***
Non ho ancora trent’anni, sono giovane, sono ancora studente, ma quante ne ho già passate. Ogni inverno che arriva soffro la fame, mi ritrovo ammalato, sperduto, povero come un mendicante e dove non mi ha sbattuto il destino, dove non sono stato! Ma la mia anima, nonostante tutto, in ogni singolo istante, di giorno e di notte, è sempre stata colma di inspiegabili presentimenti.
***
La morte non vuole gli stupidi.
***
La medicina è la mia legittima sposa, mentre la letteratura è la mia amante: quando mi stanco di una, passo la notte con l’altra.
***
I pregiudizi e tutte le brutture della vita sono utili perché col tempo si trasformano in qualcosa di utile, come il letame in humus.
***
La capacità di credere in qualcosa è una facoltà dello spirito. Gli animali non la possiedono, i selvaggi e gli uomini poco evoluti hanno la paura e i dubbi. Essa è accessibile solo agli organismi superiori.
***
L’università sviluppa tutte le doti, compresa la stupidità.
***
***
***
***
***
***
L’uomo è dotato di intelligenza e di forza creativa per accrescere ciò che gli è stato dato; ma fino ad ora egli, invece di creare, non ha fatto altro che distruggere. Non c’è minima compassione né per i boschi, né per gli uccelli, né per gli animali, né per i propri simili… per nessuno. Bisogna essere barbari insensati per distruggere ciò che non possiamo creare.
***

Ma all’improvviso… Nei racconti si trova spesso questo “all’improvviso”. Gli autori hanno ragione: la vita è così piena di cose inaspettate.
***
Gli infelici sono egoisti, cattivi, ingiusti, crudeli e meno capaci degli sciocchi di comprendersi reciprocamente. L’infelicità non unisce, ma disunisce gli uomini, e perfino là dove parrebbe che gli uomini dovessero essere legati dalla identità del loro dolore, si commettono molte più ingiustizie e crudeltà che in mezzo a gente relativamente contenta.
***
Quell’orrore ripugnante, a cui si pensa quando si parla della morte, era assente dalla camera. Nell’irrigidimento generale, nella posa della madre, nell’indifferenza del viso del dottore c’era qualcosa che attirava e commoveva, e precisamente quella delicata e quasi inafferrabile bellezza del dolore umano che non si arriverà tanto presto a comprendere e a descrivere e che soltanto la musica, a quanto pare, sa esprimere.
***
Il suo cervello assonnato si rifiutava ai pensieri ordinari, si annebbiava, tratteneva unicamente le immagini fantastiche, favolose, che hanno questo di buono: nascono da sé nel cervello senza sforzo di chi pensa, e da sé (non c’è che da scrollare la testa) scompaiono senza traccia.
***
Dietro la porta dell’uomo felice dovrebbe esserci qualcuno con un piccolo martello fra le mani che, battendo costantemente, rammentasse che l’infelicità esiste e, passata la breve felicità, sopraggiungerà immancabilmente.
La capacità di credere a qualcosa è una facoltà dello spirito.
***
Una scienza nazionale non esiste, così come non esiste una tavola pitagorica nazionale. Quel che è nazionale, non è scienza.
***
La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove.
***
Continuo a non avere un punto di vista politico, religioso e filosofico ben definito. Cambio ogni mese, per cui sono costretto a limitarmi a raccontare come i miei eroi si amano, si sposano, mettono al mondo dei figli, parlano e muoiono.
***
Le nostre sofferenze si trasformeranno in gioia per quelli che vivranno dopo di noi: la felicità e la pace scenderanno sulla terra e gli uomini ricorderanno con gratitudine e benedizione coloro che vivono adesso.
***
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web, quindi considerati di pubblico dominio, usati a scopo meramente didattico o decorativo, e appartenenti a google, a youtube, a Pinterest e ai legittimi proprietari. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo lacapannadelsilenzio@yahoo.it e saranno immediatamente rimossi.
 Copyright secured by Digiprove © 2015
Copyright secured by Digiprove © 2015


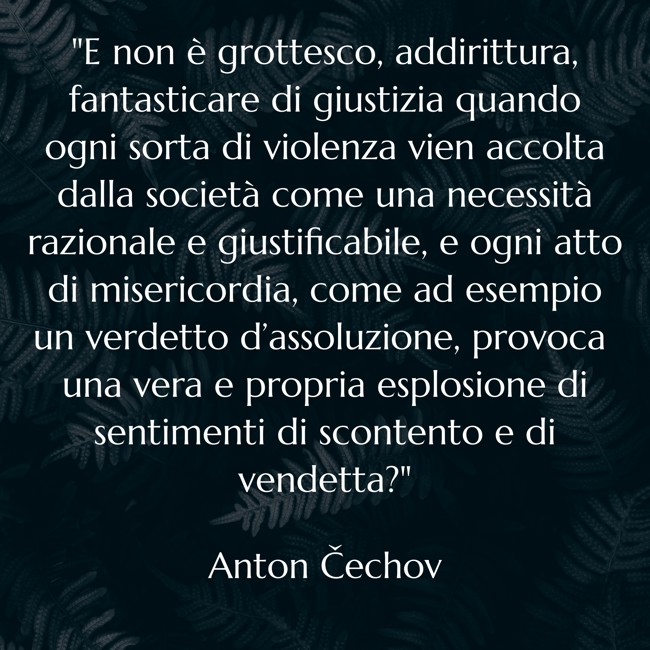

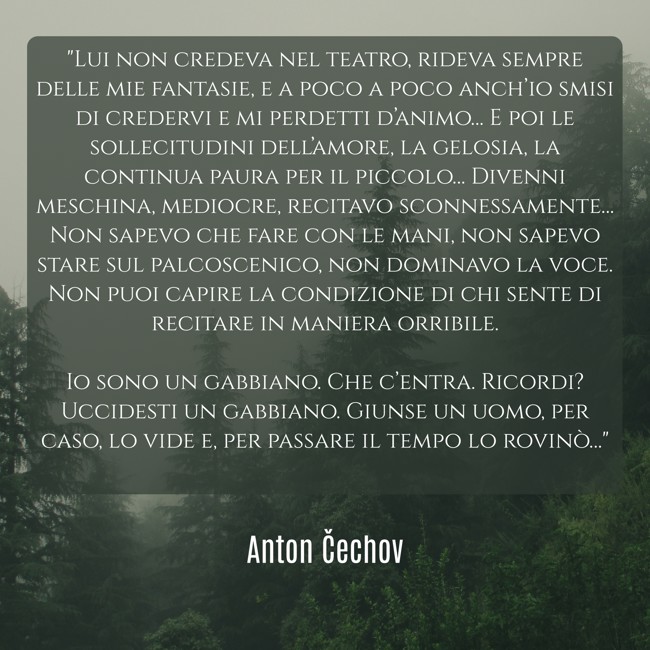
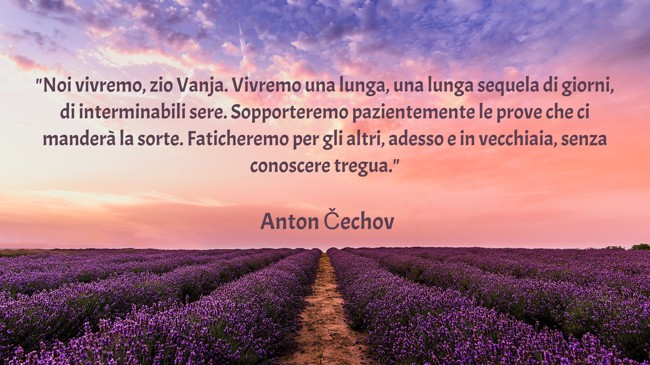

Free Piano
The article has really peaks my interest. I am going to like your site and preserve checking for brand spanking new information from feed RSS :-).
Thank you, Free Piano 🙂
[…] piedi e gridare forte semplicemente i nomi degli autori che ama. Io amo Kafka, Flaubert, Tolstoj, Cechov, Dostoevskij, Proust, O’Casey, Rilke, Garcìa Lorca, Keats, Rimbaud, Burns, Brönte, Austen, […]
[…] molte più ingiustizie e crudeltà che in mezzo a gente relativamente contenta.Anton Čechov, “Nemici”Ph Web Di nient’altro viviamose non dei nostri poverima splendidi […]
[…] Idiozia. Romain Gary *** Meglio perire per mano degli stupidi che averne gli elogi. Anton Čechov *** Un genio incompreso è un tragico errore, un idiota incompreso è una tragedia […]
[…] di Puškin, poiché prefigura la grande era del teatro russo che esploderà con Čechov e i drammaturghi del tardo Ottocento. Grazie alla sua abilità nel mescolare dinamiche […]