Animo inquieto e passionale dall’esistenza movimentata, Michelangelo Merisi, conosciuto in tutto il mondo con il nome di Caravaggio, trasmette nella sua arte i mutamenti interiori intercorsi durante la sua breve ma intensa esistenza il cui emblematico uso della luce, con il passare degli anni, va sempre più drammaticamente eclissandosi lasciando prevalere raffigurazioni di scene crude e angoscianti.
La sua arte sorge da uno spirito anticonformista ben evidente anche nelle sue scelte spirituali ed esistenziali.
Annoverato tra gli artisti che hanno più suggestionato la formazione di correnti artistiche rivoluzionarie per opere che, viste da vicino, sconvolgono l’animo dell’osservatore, Caravaggio esprime nei soggetti ritratti una fisicità tridimensionale grazie ad un meticoloso studio della luce volto ad evidenziare i volumi di corpi che sembrano irrompere inaspettatamente dal buio del dipinto.
Il numero dei quadri in cui è presente lo sfondo è piuttosto esiguo ed occupa una posizione secondaria rispetto alle figure umane, protagoniste assolute nelle opere di questo straordinario artista, prototipo di quella genialità e sregolatezza facilmente riscontrabile in tutti i grandi artisti e intellettuali, poco disponibili ad adattarsi alle regole imposte dalle società di tutti i tempi.
Per poter attuare quell’affascinante gioco di luci, che ipnotizza e stordisce con potenza l’osservatore (e chi ha avuto modo di poter vedere le opere di Caravaggio non può negare le profonde emozioni suscitate da tale visione), Caravaggio pone delle lanterne in alcuni luoghi da lui prescelti in modo tale da illuminare i suoi modelli solo nella parte che desidera porre in maggiore evidenza.
Nato probabilmente a Milano il 29 settembre del 1571, vive la sua giovinezza in quel paese lombardo in provincia di Bergamo da cui prende il nome con cui è noto.
La sua prima formazione avviene a Milano presso il pittore manierista Simone Peterzano, dove il giovanissimo Caravaggio subisce il fascino del realismo e del luminismo dei pittori del Cinquecento.
Nel 1592 si reca a Roma, in quel periodo centro di riferimento culturale di notevole importanza, e dopo aver lavorato inizialmente con pittori mediocri la cui “arte” è semplicemente indirizzata al commercio, riesce ad entrare nella bottega del cavaliere Giuseppe Cesari d’Arpino, pittore di spicco del periodo.
La sua svolta artistica avviene nel 1595, grazie all’incontro con il cardinale Del Monte, il quale, colpito dal talento del pittore, gli commissiona alcune opere.
Il primo periodo artistico di Caravaggio è incentrato soprattutto su opere di soggetti mitologici-allegorici usando come modelli giovani seducenti raffigurati in atti simbolici che rimandano all’amore e alla sensualità. Giovani comuni che il pittore ingaggia per strada e che hanno suscitato in alcuni critici il sospetto di omosessualità del pittore.
Che vi sia qualcosa di vero in queste supposizioni non ritengo sia di grande importanza e che il nostro artista frequentasse prostitute, avesse presunti amanti dello stesso sesso e amasse trascorrere il tempo libero dentro taverne malfamate poco importa; è noto a tutti il suo temperamento sregolato e fuori dagli schemi.
Di questo primo periodo una delle opere più interessanti dal punto di vista innovativo è “Ragazzo morso da un ramarro“.

“Ragazzo morso da un ramarro”, 1594-95, olio su tela. Firenze, Fondazione di studi di storia dell’arte Roberto Longhi
È già presente in questo dipinto un evidente contrasto tra luce ed ombra e l’assenza di uno sfondo significativo che distragga l’osservatore da ben altri particolari che l’artista vuole evidenziare; la smorfia di dolore è il soggetto principale dell’opera, resa in modo realista grazie a bruschi movimenti di chiaroscuro che lasciano in penombra alcune parti e illuminano altre zone del viso. In primo piano si nota un vaso da fiori trasparente che riflette la luce, probabilmente proveniente da una finestra. L’artista lascia alla nostra immaginazione lo sfondo del quadro. Uno dei simboli più evidenti che possono trarsi dall’opera può essere colto dalla natura morta in cui emergono le ciliegie (il lato effimero del piacere), la rosa recisa e pronta a sfiorire in poco tempo insieme alla presenza inquietante del ramarro, recante con sé il dolore e la fugacità della vita.
Grazie alla lungimiranza del cardinale Del Monte, che riesce a cogliere la genialità del giovane artista, Caravaggio viene introdotto nel mondo dell’aristocrazia romana e prende vita una nuova stagione artistica indirizzata alla pittura sacra realizzata su tele di maggiori dimensioni. Il dipinto che meglio rappresenta questo periodo è “Riposo durante la fuga in Egitto“, 1596-97, olio su tela. (Roma, Galleria Doria Pamphilj)
Apparentemente semplice il soggetto di un dipinto che sembra diviso in due parti, non facile l’interpretazione, se non fosse per il volto provato dalla fatica di Giuseppe che assurge a simbolo di un’umanità dolente, costretta a fuggire dalle persecuzioni e che trova il suo conforto nell’arte e nella musica. Ma ciò che maggiormente emoziona di questo capolavoro non è solo quella sublime e armonica combinazione di senso del divino e senso del reale, ma l’umanizzazione di figure considerate sacre e che appaiono simili a tutti noi. Niente aureole per la Madonna e il Bambino; Maria è una madre che abbraccia amorevolmente il proprio figlio e lo stringe al suo petto così come tutte le donne che vivono la magia della maternità.
Già agli inizi del Seicento Caravaggio è un artista affermato e numerose sono le commissioni ricevute non solo per le collezioni private delle maggiori famiglie aristocratiche romane, ma anche per le loro cappelle private ubicate nelle grandi chiese. Il nuovo percorso artistico del pittore può essere rappresentato dalla “Vocazione di San Matteo” in cui comincia a delinearsi la manifestazione del sacro nella storia e l’illuminazione divina che si svela nella tragicità della vita degli esseri umani.
Anche in altri due dipinti di quel periodo l’artista opera una rivoluzione nella narrazione di episodi sacri; le figure ritratte mostrano l’umile quotidianità di ogni essere umano e nei due meravigliosi quadri “Crocifissione di San Pietro” (1601) e “Conversione di San Paolo” (1601), l’attenzione di Caravaggio si concentra sulla potente connotazione realistica che riesce a trascinare emotivamente l’osservatore.
Costretto a modificare le suddette opere due volte, probabilmente per l’estremo realismo ritenuto sconveniente, nella “Crocifissione di San Pietro” è particolarmente evidente il primo piano dei piedi sporchi del santo e la luminosità concentrata solamente su quell’uomo, vittima di una barbara esecuzione. Il simbolismo è piuttosto chiaro; le altre figure, di cui non si vede il volto, sembrano quasi inghiottite dall’oscurità dello sfondo.
Lo stesso si può notare nel quadro “Conversione di San Paolo” in cui il santo viene investito da una luce soprannaturale, simbolo della sua conversione che lo induce ad intraprendere il cammino verso una rivelazione salvifica.
Nonostante la notorietà del pittore, la sua incessante ricerca del realismo ed il suo studio per rendere i suoi dipinti ancora più veri, cominciano a levarsi grida di scandalo verso le sue opere, di cui spesso viene rifiutata l’esposizione nelle chiese, così come accade alla “Madonna di Loreto“, nota anche con il nome della “Madonna dei pellegrini“.
Il motivo di un simile scandalo è perfettamente comprensibile: quando un artista rifiuta i canoni accademici dell’epoca e, se noi non riusciamo a trovare niente di sacrilego in quest’opera, probabilmente accade solamente perché sono ben altri gli schemi convenzionali di oggi e forse non conosciamo nemmeno le opere di autori che non riescono ad emergere perché stroncate dalla critica o ritenute oscene.
Il quadro raffigura due umili pellegrini inginocchiati davanti alla Madonna, ma l’artista rifiuta l’iconografia tradizionale di Maria che arriva in volo insieme a due angeli. Ecco lo scalpore suscitato dal quadro: un’opera così “sacrilega” non può essere esposta in una chiesa!
L’elemento sovrannaturale non appare nemmeno in un altro dei suoi capolavori, “Morte della Vergine“, altra opera rifiutata dall’ordine dei Carmelitani Scalzi. In un ambiente sobrio e privo di ornamenti appare il corpo senza vita di una prostituta morta per annegamento e di conseguenza con il ventre gonfio, attorniata da coloro che dovrebbero essere gli apostoli, rappresentati con il viso popolano, vestiti di abiti miseri e profondamente addolorati. La Vergine Maria assume il volto di una prostituta: lo scandalo del bigottismo dell’epoca esplode in modo potente. Quegli esseri miseri focalizzano la loro attenzione solamente in questi particolari insignificanti senza cogliere la bellezza di un’opera la cui potenza della luce sembra quasi provenire da un proiettore per evidenziare l’intensa espressività e spiritualità dei personaggi ritratti. Un’altra opera anticonvenzionale che desta scalpore a quei tempi, ma che sprigiona ancora oggi, a distanza di molti secoli, un fascino senza tempo. I quadri di Caravaggio, nonostante il disprezzo dei suoi contemporanei, fatta eccezione il pittore fiammingo Rubens che acquista il dipinto in questione, ben consapevole della straordinaria innovazione rivoluzionaria racchiusa nell’opera, hanno ottenuto quell’immortalità che l’artista si prefigge.
L’ostracismo nei suoi confronti si accresce anche a causa di altri drammatici eventi che lo vedono arrestato più volte per possesso abusivo di armi, una querela per aver lanciato in faccia un piatto ad un garzone d’osteria, ferito un notaio per motivi legati alla sua storia d’amore con una donna e una denuncia dalla sua padrona di casa per il mancato pagamento dell’affitto, denuncia a cui l’artista risponde prendendo a sassate la finestra della donna.
L’episodio però che cambia drammaticamente la sua vita accade il 28 maggio del 1606: durante una lite, il pittore, ferito da Ranuccio Tomassoni da Terni, a causa di una donna contesa da entrambi, ferisce mortalmente l’avversario e viene condannato a morte dal papa.
Per sfuggire alla condanna, lascia in fretta Roma e inizia un periodo di vagabondaggi che lo condurranno a Napoli, in Sicilia e a Malta. Al fine di ottenere la grazia esegue alcuni dipinti per i Cavalieri di Malta, ma nel 1608, coinvolto in un’altra rissa, viene nuovamente imprigionato.
Riesce ad evadere e a raggiungere la Sicilia, dove si stabilisce e continua a dipingere realizzando delle opere che manifestano il suo nuovo stile in cui le pennellate diventano più energiche e rapide ed i personaggi ritratti si rimpiccioliscono lasciando emergere uno sfondo per lo più scarno e sempre più scuro ed angosciante.
Una delle opere più emblematiche dell’ultimo Caravaggio viene realizzata durante la sua breve permanenza a Malta. Si tratta di uno dei suoi dipinti più drammatici, “La Decollazione di San Giovanni Battista“, realizzata nel 1608, poco prima di essere arrestato.

“Decollazione di San Giovanni Battista”, 1608, olio su tela, La Valletta (Malta), Oratorio di San Giovanni Battista
Per la prima volta la cruenta decollazione di San Giovanni Battista viene raffigurata in tutta la sua drammaticità da Caravaggio, che decide di proporre il momento più tragico dell’episodio narrato dai Vangeli di Marco e Matteo in cui il re Erode decide di acconsentire al capriccioso desiderio della bella Salomè di vedere la testa di Giovanni Battista su un vassoio d’argento. Quasi tutto lo sfondo viene lasciato drammaticamente vuoto e le figure ritratte appaiono solo grazie ad un raggio di luce mirato a far sì che lo sguardo dell’osservatore si concentri su quella scena, dalla struttura piramidale, profondamente ricca di pathos. Ciò che maggiormente attira l’attenzione, oltre all’immagine agonizzante di Giovanni Battista è quel fiotto di sangue che fuoriesce dalla ferita del santo e su cui il pittore pone la sua firma. Un particolare macabro che ben descrive il tormento interiore dell’artista.
Due anni dopo, quando il pittore si stabilisce a Napoli, quelle vibranti pennellate appaiono ancora più evidenti in un’altra inquietante opera che appare quasi come il grido disperato del suo autore. Il dipinto in questione, “David con la testa di Golia“, mostra un autoritratto dell’autore in quel macabro trofeo retto dalla mano di David.
Il viso del pittore segnato dalle rughe e la bocca aperta in una smorfia di dolore rappresentano chiaramente un Caravaggio sfinito e profondamente annientato dal dolore. La speranza di poter ricevere la grazia dal Papa Paolo V per quegli errori compiuti nella sua vita non è ancora stata abbandonata e l’artista invia una lettera al cardinale Scipione Borghese affinché possa intercedere nei suoi confronti allegando questo quadro.
Se si osserva con attenzione la spada di David si legge la scritta “H-AS OS” (dal latino Humilitas Occidit Superbiam – l’umiltà uccide la superbia). Gli studiosi concordano sull’interpretazione di questo quadro che raffigura Caravaggio giovane nel volto di David e il Caravaggio provato dalla vita nel viso di Golia; un doppio autoritratto che potrebbe rappresentare la rinascita di quel grande pittore, stroncato poi da un attacco di febbre proprio quando la grazia gli viene concessa e che muore durante il viaggio intrapreso sulla via di ritorno a Roma. A soli trentanove anni, il 18 luglio del 1610, si spegne a Porto Ercole uno dei più grandi pittori della storia dell’arte il cui linguaggio rivoluzionario, che coglie mirabilmente l’espressione dei sentimenti umani, sarà fonte d’ispirazione per chi non riuscirà a restare impassibile dinnanzi ad una simile bellezza impressa nelle sue tele.
Di seguito alcune citazioni di Caravaggio ed il parere di critici di enorme rilevanza.
Quando non c’è energia non c’è colore, non c’è forma, non c’è vita.
***
Tanta manifattura mi era a fare un quadro buono di fiori, come di figure.
***
Prendo in prestito dei corpi e degli oggetti, li dipingo per ricordare a me stesso la magia dell’equilibrio che regola l’universo tutto. In questa magia l’anima mia risuona dell’Unico Suono che mi riporta a Dio.
***
Filippo Neri disse a Caravaggio: “vedo in te due lupi che lottano uno contro l’altro e devono sbranarsi a vicenda.” Caravaggio rispose: “Quale dei due riuscirà a vincere?” Filippo Neri ribatté: “Quello che tu avrai nutrito di più.”
***
Come è possibile che ancora oggi, dopo Kandinsky o Mondrian, il passante più casuale, o il patito di Pollock o di Rauschenberg, o il più condiscendente elettore dell’arte ludica, entri in San Luigi dei Francesi e senta riaprirsi in petto una piaga che credeva chiusa per sempre?
Renato Guttuso
***
Quello veramente da tener di mira è la sua nuova concezione stilistica. La nota che la caratterizza è una ricerca così tenace di concisione, da ricordare la sobrietà dei grandi periodi arcaici. A tal fine il Caravaggio si serve principalmente di due mezzi: della luce e della composizione. Egli, come è noto, immerge le sue scene nell’oscurità, investendole di un getto violento di luce radente, in modo che alcune parti soltanto affiorino dalle tenebre nella luce. Questa, creduta fino ad oggi, e forse dagli stessi suoi seguaci, una trovata realistica fu, caso mai, una concessione alla fantasia – come pare la interpretasse lo stesso Rembrandt –, ma soprattutto una ricerca di unità e di stile: un mezzo a mettere in valore certe parti e linee essenziali delle cose, facendole affiorare nella luce e ad eliminarne nelle tenebre altre secondarie, inutili o dannose ad una concisa rappresentazione. L’altro mezzo che il Caravaggio impiega per raggiungere l’unità stilistica riguarda, dunque, la composizione del quadro. Per il primo Michelangiolo aveva decisamente spezzato la secolare uniformità degli schemi compositivi a linee e piani paralleli “al quadro”, e aveva mostrato quante maggiori risorse di movimento e di energia offrisse l’impostatura, diciamo, in tralice di certe sue figure; risorsa che il Tintoretto aveva spinto al colmo, limitandola però anche lui troppo a singole figure isolate. Era riserbato al Caravaggio di coronare la geniale iniziativa dei suoi precursori estendendo questo stesso sistema costruttivo a tutta quanta la compagine della composizione, in modo da ottenere in un sol tratto, con sintesi insuperata, il massimo risultato di senso plastico e dinamico.
Matteo Marangoni
***
Nessuna forma tipica del barocchismo si ritrova in Caravaggio. Egli ha uno svolgimento in profondità e in chiarezza che lo riporta piuttosto presso agli artisti del Quattrocento che ai contemporanei. C’è in lui una profondità epica, una umanità, una volontà apostolica, lontanissime dall’atteggiamento barocco: la sua formazione raccolta, approfondita tutta in un senso, costituisce la sua solitudine storica nel barocchismo ed oltre.
Carlo Ludovico Ragghianti
***
Complessa è la natura di questo “stil nuovo”, di questa forma unica e non riducibile ad altra, che Caravaggio inventa. Essa è insita nell’armonia dei suoi colori e nella particolare natura del suo dipingere: armonia rara e sottile, composta da una specifica scelta di toni e da una particolare maniera d’impiegarli; pittura raffinata la cui materia possiede la purità cristallina che ritroveremo più tardi, analoga se non simile, in Vermeer; con la novità e qualità della sua tavolozza egli colpì i contemporanei a tal punto che perfino i nemici ne riconobbero i meriti: in lui la tecnica stessa è poesia. L’originalità del suo genio sta nel saper porre i personaggi in uno spazio che non ha di per sé esistenza plastica, che non è né definito né limitato, ma soltanto il luogo delle possibilità plastiche, il nulla da cui nascono esseri e cose, l’informe da cui le forme emergono; dal contrasto che ne deriva tra figure aventi la rigorosa pienezza della statua e uno spazio confidato alle incertezze del chiaroscuro e a magici misteri pittorici, nasce più sorprendente e anche perciò più ricca di contenuti poetici la monumentalità della composizione caravaggesca.
René Jullian
***
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web, quindi considerati di pubblico dominio, usati a scopo meramente didattico e appartenenti a google, a youtube e ai legittimi proprietari. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo lacapannadelsilenzio@yahoo.it e saranno immediatamente rimossi.
 Copyright secured by Digiprove © 2015
Copyright secured by Digiprove © 2015
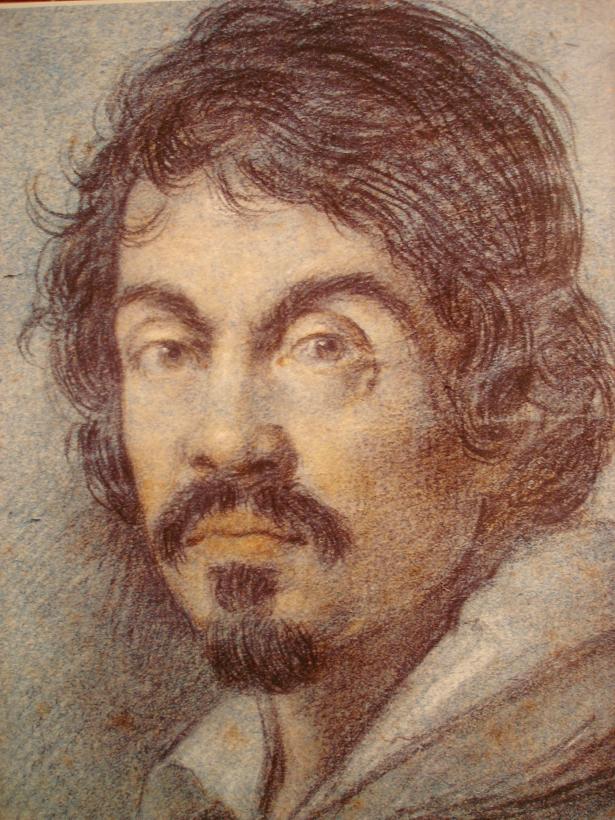



[…] “Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi”. La Natività umile del Caravaggio. […]
[…] è noto per i suoi quadri violenti e rivoluzionari, vicini ad artisti “maledetti” come Caravaggio, Goya e Gèricault in cui l’alternarsi della formazione classica ad un linguaggio espressivo […]
[…] accade non solo con l’uso della luce, la cui singolarità rimanda agli studi pittorici di Caravaggio, ma anche grazie ad una tecnica impersonale e illustrativa che accresce nell’osservatore la […]
[…] pastosa e ad un’illuminazione misteriosa e simbolica, pur richiamando l’influenza di Caravaggio, si allontana pian piano da quest’ultimo lasciando il posto a una caratteristica pittura […]
[…] olandese”, Jan Vermeer interpreta in modo molto personale gli studi del chiaroscuro di Caravaggio e di Rembrandt, creando dipinti di rara poesia che traggono ispirazione dalla realtà quotidiana […]
[…] e avevamo ingaggiato Promayet a suonare il violino davanti a mio padre». L’influenza di Caravaggio è molto evidente in questa raffigurazione realistica di una scena di vita quotidiana […]
[…] nature morte e paesaggi più pacati rispetto al primo periodo la cui influenza di Caravaggio e di Courbet appare molto evidente in un utilizzo ancora dilettantistico di colori […]