Samuel Beckett è considerato uno dei più originali e complessi scrittori del Novecento. Nelle sue opere teatrali e narrative mostra il senso di desolazione e di vuoto che pervade il mondo, attuato attraverso l’uso di dialoghi composti da semplici e comuni parole di ogni giorno per sottolineare i limiti della nostra comunicazione che, nonostante gli sforzi, non riesce pienamente a formulare il proprio pensiero. Nella sua produzione teatrale il linguaggio è direttamente relazionato all’azione e mimica e silenzio giocano il ruolo principale proprio per sottolineare l’importanza del non detto e la menzogna della comunicazione umana.
Scrive le sue opere in inglese e in francese e ciò lo costringe ad uno stile rigoroso nella scelta delle parole e delle frasi, sebbene riesca a ridurre il linguaggio all’essenziale condensando pensieri ed espressioni e rimuovendo tutto ciò che è da considerarsi superfluo. Quel suo modo di esprimere se stesso potrebbe apparire talvolta criptico, ma nasce dalla sua esigenza di esprimere simbolicamente la futilità e l’insensatezza dell’esistenza umana.
Nato a Dublino probabilmente il 13 aprile del 1906 (alcuni registri anagrafici riportano la data di nascita del 14 giugno) da una famiglia protestante della classe media, studia Lingue Moderne presso il Trinity College e si laurea con risultati eccellenti nel 1928. Dopo aver insegnato per un breve periodo a Belfast, si trasferisce a Parigi per svolgere la professione di lettore di lingua inglese presso L’École Normale Supérieure dove conosce James Joyce, che influenzerà notevolmente il suo pensiero. L’amicizia tra Joyce e Beckett si spezzerà quando Samuel rifiuterà di sposare la figlia di James, affetta da schizofrenia. Dopo un po’ di tempo da tale episodio i due torneranno amici.
Torna in Irlanda nel 1930 e accetta l’incarico di lettore di lingua francese al Trinity College, ma presto si pentirà di tale scelta per la pedanteria dell’ambiente accademico irlandese cui gioca pure uno scherzo per mostrare la propria avversione. Appena due anni dopo rassegna le dimissioni e intraprende alcuni viaggi in Europa. Ha già cominciato a dedicarsi all’attività letteraria e ciò gli procura scontri con la sua famiglia, per nulla entusiasta della scelta di Samuel.

Le liti familiari gli causano un esaurimento nervoso e per due anni si sottopone a sedute psicoanalitiche per cercare di comprendere meglio se stesso. Grazie al suo psicoanalista, assiste ad una conferenza di Carl Gustav Jung, altra personalità che influenzerà le sue opere.
In quegli anni continuerà a scrivere e condurrà una vita disordinata segnata da abuso di alcool e da relazioni con prostitute. Conosce Suzanne Dechevaux-Dumesnil, più anziana di lui di dieci anni e se ne innamora profondamente, preferendola all’ereditiera Peggy Guggenheim. Nel 1937 si stabilisce a Parigi e diventa molto conosciuto negli ambienti intellettuali.
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale inizia a lavorare per la Resistenza come traduttore, ma il pericolo incombente di essere arrestato dalla Gestapo lo spinge a cercare riparo nelle campagne insieme a Suzanne, pur continuando a partecipare attivamente alla guerra fornendo armi ai resistenti.
Per l’attivismo mostrato nel combattere l’occupazione tedesca verrà premiato alla fine della guerra dal governo francese.
Dedicatosi interamente alla letteratura dal 1930, il periodo di maggiore creatività per Beckett si può considerare quello compreso tra il 1945 e il 1955.
Ed è proprio in quegli anni che compone l’opera ritenuta una pietra miliare del Novecento e che rivoluzionerà il teatro contemporaneo, “Aspettando Godot“.
Nel 1961 sposa con rito civile Suzanne e nel 1969 riceve il Premio Nobel per la Letteratura con la seguente motivazione: «per la sua scrittura, che – nelle nuove forme per il romanzo ed il dramma – nell’abbandono dell’uomo moderno acquista la sua altezza».
Non ritirerà mai tale premio e quell’improvvisa notorietà lo infastidisce. Dedica poco tempo a quelle che ritiene noiose interviste preferendo incontrare gli intellettuali e gli ammiratori nell’atrio di un hotel parigino, vicino la sua casa a Montparnasse.
Si spegne pochi mesi dopo la perdita della moglie, il 22 dicembre del 1989.
La coppia viene sepolta insieme e, adempiendo alla volontà di Beckett, sulla sua semplicissima lapide viene incisa una scritta che ben riassume il pensiero nichilista di questo grande scrittore: «senza colori, lunga e grigia».
Quando sentiamo pronunciare il nome di Samuel Beckett lo associamo immediatamente alla sua opera “Aspettando Godot“, ma quel lavoro teatrale, in realtà, è solo uno di una serie di capolavori da lui scritti.
 La storia dei due vagabondi che aspettano un misterioso Godot che mai comparirà, lungo una desolata strada di campagna e, durante il tempo dell’attesa, tra chiacchiere, momenti di sconforto, litigi e scene comiche, è molto conosciuta ed è abbastanza difficile aggiungere qualcosa di nuovo alla numerose interpretazioni di una delle opere teatrali più note in tutto il mondo.
La storia dei due vagabondi che aspettano un misterioso Godot che mai comparirà, lungo una desolata strada di campagna e, durante il tempo dell’attesa, tra chiacchiere, momenti di sconforto, litigi e scene comiche, è molto conosciuta ed è abbastanza difficile aggiungere qualcosa di nuovo alla numerose interpretazioni di una delle opere teatrali più note in tutto il mondo.
Quel Godot che mai arriverà potrebbe rappresentare la nostra stessa vita. Una lunga attesa di qualcosa che mai giungerà.
Ed in questa tragicommedia edificata attorno alla condizione dell’attesa si riscontra la genialità di Beckett. Lascia a tutti noi un finale aperto nel quale ognuno di noi può perdersi nell’interpretazione. Beckett, naturalmente, non ha mai fornito alcuna spiegazione. La sua frase più celebre, riguardo l’opera in questione, è «se avessi saputo chi è Godot l’avrei scritto nel copione».
I due personaggi attendono senza mai spostarsi, nemmeno quando sembra vi sia la volontà di farlo. Siamo noi esseri umani, impossibilitati a muoverci e ad operare un mutamento nella nostra vita? E chi è Godot? Qualcuno sostiene sia Dio, altri quella felicità irraggiungibile cui tutti aneliamo. Altri ancora la morte. Forse Godot simbolizza semplicemente il significato non significante di una passiva attesa. Per tale ragione non arriverà mai. Ed in quelle pagine qualche lettore può forse intravedere la propria vita; una perenne attesa che giunga qualcosa in grado di mutare il corso della propria esistenza, ma senza compiere alcuna azione affinché quel cambiamento accada. In attesa di un Godot in grado di salvare una vita spesso insignificante perché attendiamo che sia qualcun altro a mutarne il corso.

Una scena emblematica di “Aspettando Godot”
di Samuel Beckett e interpretato da Eros Bagni e Ugo Pagliai.
Pietra miliare della cultura novecentesca, l’opera ha rivoluzionato il linguaggio teatrale, fondendo citazioni teologiche e turpiloquio, e annientandone quella struttura di azioni, scene e trama, considerata intoccabile, con l’inserimento di pause e lunghi silenzi. Inoltre, per la prima volta nella storia del teatro, il protagonista è assente. E sul palcoscenico irrompe quel bizzarro mondo interiore basato su gestualità ed eccentrici non-sense.
Insomma la nostra stessa vita 🙂
Sono degne di menzione anche le altre sue opere meno conosciute, ma ugualmente interessanti.
Tra queste bisogna ricordare la trilogia di romanzi “Molloy“, “Malone muore“ e “L’innominabile“, in cui è evidente l’influenza di James Joyce. Beckett, però, si pone in antitesi con il suddetto autore evidenziando quello spreco di parole cui siamo obbligati a pronunciare pur consapevoli della tortura di comunicare proprio quello che non abbiamo da comunicare.
La trilogia si presenta come un capolavoro affascinante e oscuro che smantella il linguaggio per esplorare le pieghe più intime dell’identità e della coscienza. Molloy è un romanzo intrigante e frammentario, suddiviso in due parti che presentano prospettive diverse sulla stessa storia.
Nella prima parte, il protagonista, Molloy, è un uomo anziano e malandato che intraprende un viaggio solitario attraverso un paesaggio desolato e surreale. La sua narrazione è un labirinto di ripetizioni, digressioni e pensieri contrastanti, che svelano una mente in balia di se stessa, in cerca di significato e di riconnessione con un passato confuso, probabilmente legato alla figura materna. Il suo percorso fisico diventa così una metafora della ricerca identitaria e delle sfide nel comunicare un’esperienza interiore caotica. Nella seconda parte, la narrazione si sposta su Moran, un uomo incaricato da un’autorità misteriosa di ritrovare Molloy. La sua ricerca si svolge in un contesto altrettanto oppressivo e ambiguo, dove la logica svanisce e l’ossessione per l’ordine si trasforma in un disperato tentativo di dare un senso alla vita. Con una prosa fredda e asciutta, Moran riflette sulle difficoltà della comunicazione e sulla condizione umana, evidenziando il contrasto tra la rigidità del sistema e il caos interiore dell’individuo.il racconto si trasforma in un viaggio frammentato e surreale, dove il protagonista, alla ricerca del proprio io, si perde in paesaggi interiori caratterizzati da disperazione e umorismo amaro.
“Malone muore” si evolve in una meditazione poetica sul declino, con il tempo che si dilata e ogni pensiero che diventa un gesto disperato per non svanire nell’oblio. Strutturato come un flusso di coscienza, coinvolge il lettore in una dimensione sospesa, dove il confine tra vita e dissoluzione diventa sottile. Il protagonista, Malone, vive in una sorta di immobilità esistenziale, in cui il passare del tempo si sente quasi tangibile e le parole si trasformano in echi di un’identità in lento declino. È un uomo che si confronta con il lento ma inarrestabile declino della sua esistenza, mentre il tempo sembra muoversi in una dimensione quasi sospesa. Il racconto si snoda attraverso un insieme di pensieri, ricordi vaghi e profonde riflessioni sull’esistenza, il tutto ambientato in un contesto indefinito dove il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più sottile.
Beckett, con una scrittura minimalista e allo stesso tempo densa di intensità poetica, rende la narrazione un’esperienza quasi meditativa. Ogni silenzio e ogni pausa si fanno portali per riflessioni profonde sul significato dell’esistere e sulla fugacità della memoria. La forza di questo romanzo risiede proprio nel suo ritmo cadenzato e riflessivo, che non solo indaga il deteriorarsi del sé, ma ci invita anche a confrontarci con l’inevitabile fragilità dell’essere umano. “Malone muore“ diventa così un’occasione per riflettere sul tempo, sulla solitudine e sul significato di una vita che svanisce lentamente, lasciando il lettore con una consapevolezza intensa e, al contempo, liberatoria della propria esistenza mortale.
In “L’innominabile“ la narrazione si dissolve in un flusso di riflessioni elusivo, scaraventando noi lettori in un vortice di domande esistenziali senza risposta. Qui non troviamo una sequenza lineare di eventi; piuttosto, sperimentiamo un costante divenire, dove il linguaggio stesso si frantuma, incapace di catturare la complessità di un’identità sempre in mutamento. In questo paesaggio narrativo, ogni parola, intrisa di angoscia e solitudine, diventa un invito profondo a riflettere sulla fragilità del sé e sulla precarietà della comunicazione.
Il romanzo si configura come un’esperienza emotiva e intellettuale che sfida il lettore, costringendolo a confrontarsi con l’inconoscibilità dell’io. Beckett trasforma la scrittura in un flusso caotico e ipnotico, dove realtà e immaginazione si intrecciano, portandoci a immergerci in un abisso esistenziale. La forza del testo sta proprio nella sua capacità di evocare una tensione palpabile: ogni frase, nonostante la sua apparente frammentarietà, invita a una meditazione profonda sul senso della vita, sulla solitudine e sulla continua ricerca di un’identità che sembra scivolare via, sempre sfuggente e indefinita.
La suddetta trilogia è da considerarsi un’immersione profonda nell’angoscia dell’esistenza, un invito a confrontarsi con il vuoto e la frammentarietà dell’essere, rendendo la lettura un’esperienza quasi catartica e decisamente avvolgente.
Indimenticabili anche le altre due opere teatrali “Finale di partita“ e “Giorni Felici” in cui quel teatro dell’assurdo, di cui il nostro drammaturgo può considerarsi il maestro, porta all’estremizzazione il tema di un’esistenza priva di alcun significato.

Beckett ha lasciato un’impronta anche nel mondo del cinema, nonostante abbia una filmografia piuttosto ridotta. Il suo contributo più importante in questo campo si esprime nel cortometraggio “Film“, realizzato nel 1964. Questo è l’unico progetto cinematografico per cui Beckett ha scritto direttamente la sceneggiatura, collaborando con il regista Alan Schneider e il leggendario attore Buster Keaton, che ha interpretato il protagonista.
un cortometraggio muto che dura all’incirca 22 minuti e si addentra nel tema della percezione e dell’esistenza, ispirandosi al famoso principio del filosofo George Berkeley, “esse est percipi” (essere è essere percepito). La trama segue Keaton, un personaggio conosciuto semplicemente come “O” (l’Osservato), mentre cerca di sfuggire a qualsiasi forma di sguardo, che sia umano o meccanico, come quello di una macchina fotografica. L’unico suono che si sente nel film è un breve “shhh!”, che accentua il silenzio opprimente e l’atmosfera carica di tensione esistenziale.
Con un approccio minimalista, tipico del suo stile, “Film” esplora l’ansia di essere osservati e il conflitto interiore che ciascuno di noi affronta. La collaborazione con Keaton, un vero maestro della comicità fisica e del cinema muto, ha trasformato il cortometraggio in un’opera straordinaria, capace di mescolare il linguaggio visivo del cinema con le profonde riflessioni filosofiche tipiche di Beckett.
Il nostro scrittore non ha realizzato altri cortometraggi cinematografici, limitando il suo coinvolgimento attivo nel cinema a questa unica opera. Tuttavia, ha scritto sceneggiature per altri mezzi, come la televisione e la radio, continuando a esplorare temi come l’alienazione, l’identità e il vuoto esistenziale. Ad esempio, opere come “Eh Joe” (1965) per la televisione dimostrano la sua abilità nell’adattare il suo stile a formati visivi, anche se non rientrano nella categoria dei cortometraggi cinematografici.
Tutta la produzione di Beckett ha un chiaro intento filosofico; non gli interessa narrare storie, ma è piuttosto interessato a porre l’attenzione su eventi e protagonisti che mettano in mostra la tragicità dell’esistenza umana e la mancanza assoluta di senso in questo percorso chiamato vita.
Per Beckett l’uomo non è altro che “un qualcosa circondato dal nulla” senza possibilità alcuna di salvezza. Nel mondo da lui rappresentato non s’intravede mai qualcosa in cui credere e per cui valga la pena di lottare. È una realtà statica, senza ideali e ogni suo personaggio, quasi sempre rinchiuso in se stesso, trascorre quel breve cammino denominato “vita” in una solitudine che si consuma “dal ventre alla tomba“. L’impossibilità di comunicare il proprio io e di solidarizzare con le pene altrui rende la vita dei personaggi di Beckett illogica e assurda. E per poter meglio rendere il dramma della condizione umana Beckett utilizza un linguaggio volto ad evidenziare l’incapacità di comunicare ed il parlare si tramuta in un modo di colmare quel vuoto che ruota intorno a noi.
Un piccolo omaggio a questo grande scrittore con una raccolta delle sue citazioni più significative domandandomi e domandandovi se la percezione che abbiamo della realtà che ci circonda, con il suo chiacchiericcio spesso superficiale per riempire quella bellezza del silenzio che forse riuscirebbe a rasserenare l’uomo contemporaneo, sia così assurda come il grande Beckett ha fatto notare e se probabilmente l’unica salvezza è quella di tapparsi le orecchie e comunicare in modo autentico.
Ma forse non è facile.
L’uomo di buona memoria nulla ricorda, perché nulla dimentica.
***
Le idee si assomigliano in modo incredibile, quando si conoscono.
***
Le lacrime del mondo sono immutabili. Non appena qualcuno si mette a piangere, un altro, chi sa dove, smette.
***
Nasciamo tutti quanti matti. Qualcuno lo rimane.
***
Estragone: Siamo contenti. (Silenzio.) E che facciamo, ora che siamo contenti?
Vladimiro: Aspettiamo Godot.
Estragone: Già, è vero.
***
Non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!
***
Vi dirò una cosa, quando le assistenti sociali vi offrono di che non svenire, per graziosa elargizione, cosa che per loro è un’ossessione, avete un bel tentare la fuga. Vi inseguiranno fino ai confini della terra, con l’emetico in mano. Quelli dell’esercito della salvezza non sono da meno. No, contro il gesto caritatevole non c’è difesa, che io sappia. Si china il capo, si tendono le mani tutte tremanti e giunte e si dice grazie, grazie signora, grazie mia buona signora. A chi non ha nulla è proibito non amare la merda.
***
Non voler dire, non sapere ciò che si vuol dire, non poter dire ciò che si crede di voler dire, e dire sempre, o quasi, ecco cosa è importante non perdere di vista, nell’ardore della stesura.
***
La mia vita, la mia vita, ora ne parlo come d’una cosa finita, ora come d’una burla che dura ancora, e ho torto, perché è finita e perdura insieme, ma con quale tempo del verbo esprimerlo?
***
Ascolto e mi sento dettare un mondo congelato in perdita d’equilibrio, sotto una luce debole e calma e niente di più, sufficiente per vedere, capite, e congelata anch’essa. E sento mormorare che tutto si flette e cede, come sotto dei pesi, ma qui non ci sono pesi, e anche il suolo, inadatto a reggere, e anche la luce, verso una fine che sembra non debba mai esserci. Perché che fine può esserci a queste solitudini in cui non ci fu mai vero chiarore, né verticalità, né solida base, ma sempre queste cose pencolanti, slittanti in un franare senza fine, sotto un cielo senza memoria di mattino né speranza di sera. Queste cose, quali cose, venute da dove, fatte di che? E sembra che qui nulla si muova, né mai si sia mosso, né mai si muoverà, salvo io, che non mi muovo neanch’io quando sono qui, bensì osservo e mi mostro. Sì, è un mondo finito, malgrado le apparenze, è la sua fine che lo ha suscitato, è finendo che è cominciato, è abbastanza chiaro? E anch’io sono finito, quando ci sono, gli occhi mi si chiudono, le mie sofferenze cessano e io finisco, piegato come non possono esserlo i viventi.
***
È al mattino che bisogna nascondersi. La gente si sveglia, fresca ed efficiente, assetata d’ordine, di bellezza e di giustizia, ed esige la contropartita.
***

Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio.
***
Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio.
***
La migliore ragione che si può dare per credere […], è che così è più divertente. Non credere […] è una noia. Noi non ci preoccupiamo di cambiare. Semplicemente non possiamo sopportare di annoiarci.
***
Una tarda sera nel futuro.
La tana di Krapp.
[…]
Trentanove anni, oggi, sano come un pesce, a parte la mia vecchia debolezza, e intellettualmente ho adesso ogni motivo di credere sulla… (esita)…cresta dell’onda… o da quelle parti. Celebrata l’orrenda ricorrenza, come sempre in questi ultimi anni, tranquillamente, alla Taverna. Non un’anima. Rimasto a sedere davanti al fuoco con gli occhi chiusi, a separare il grano dalla pula. Buttata giù qualche annotazione sul rovescio di una busta. Felice di essere di nuovo nella mia tana, nei miei vecchi stracci. Appena mangiato, mi spiace dirlo, tre banane, e solo con difficoltà mi sono astenuto da una quarta. Micidiale per un uomo nel mio stato.
***
Presto, malgrado tutto, sarò del tutto morto.
***
Il sole splendeva, non avendo altra alternativa, sul niente di nuovo.
***
Non c’è niente di più comico dell’infelicità.
***
Pozzo: Ci danno la vita a cavallo di una tomba. Il giorno splende in un istante; ed è subito notte.
***
E non smetteva mai di parlare, mentre io non aprivo bocca che per domandare, di quando in quando, e sempre più debolmente, in che città eravamo.
***
[Descrivendo la sua decisione di abbandonare la madrelingua inglese, per scrivere in francese] Potete includermi nella lugubre categoria di quelli che, se dovessero agire nella più piena consapevolezza di quello che stanno facendo non agirebbero mai.
***
Com’è difficile parlare della luna! È così scema la luna. Dev’essere proprio il culo quello che ci fa sempre vedere.
***

Quando si è nella merda fino al collo, non resta che cantare.
***
Niente è più reale del nulla.
***
Prima balla, poi pensa. È l’ordine naturale.
***
Tutte le arti si assomigliano: un tentativo per riempire gli spazi vuoti.
***
Non posso continuare. Continuerò.
***

Niente è più ridicolo della disgrazia, altrui naturalmente.
***
Che cosa so del destino dell’uomo? Potrei dirvi di più a proposito dei ravanelli.
***
Questo è il modo in cui sono fatto – o perdono qualcosa subito o non la perdono mai.
***

Hamm: “La natura ci ha dimenticato”.
Clov: “Non c’è più natura”.
Hamm: “Non c’è più natura! Tu esageri”.
Clov: “Almeno nelle vicinanze”.
***
Vladimir: “Questo ci ha fatto passare il tempo”.
Estragon: “Ma sarebbe passato in ogni caso”.
Vladimir: “Sì, ma non così rapidamente”
***
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web, quindi considerati di pubblico dominio, usati a scopo meramente didattico o decorativo, ed appartenenti a Pinterest, a google, a youtube e ai legittimi proprietari. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo lacapannadelsilenzio@yahoo.it e saranno immediatamente rimossi.
 Copyright secured by Digiprove © 2015
Copyright secured by Digiprove © 2015



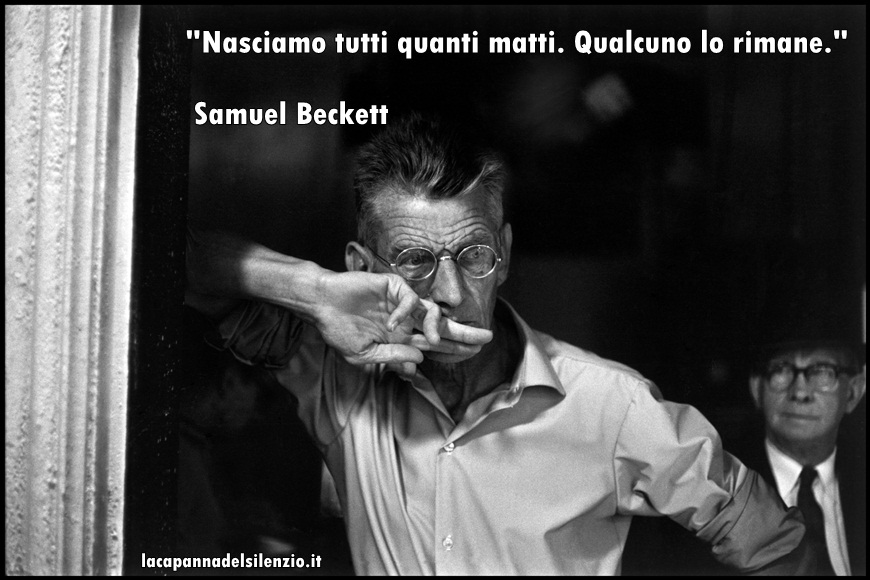

[…] Download ImageMore @ lacapannadelsilenzio.it […]